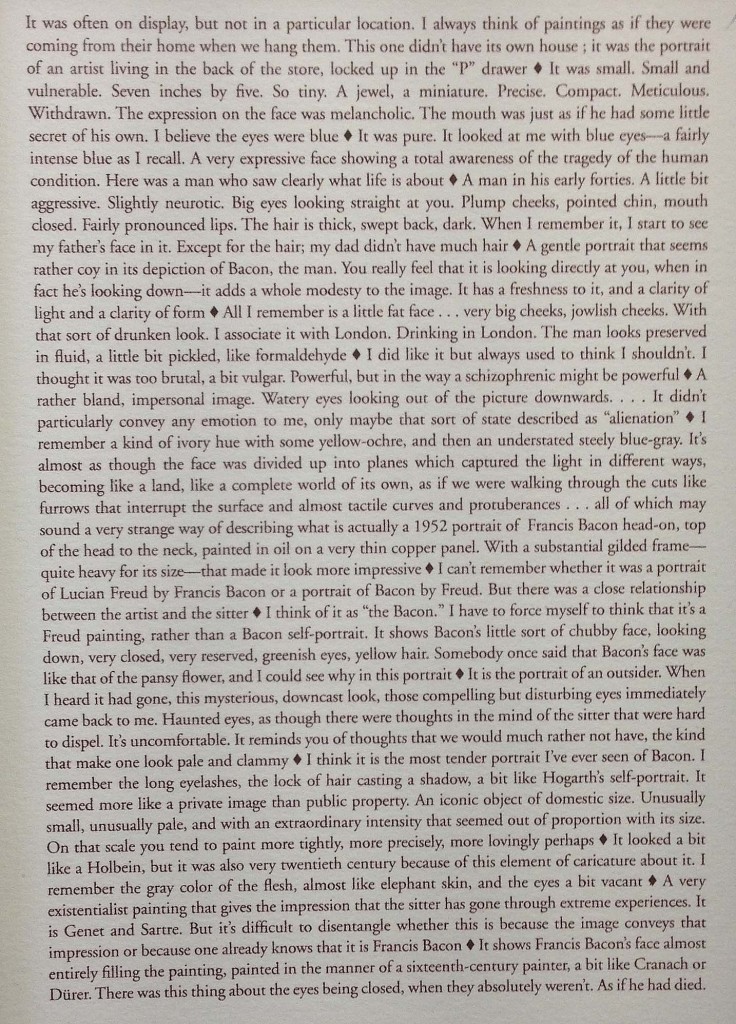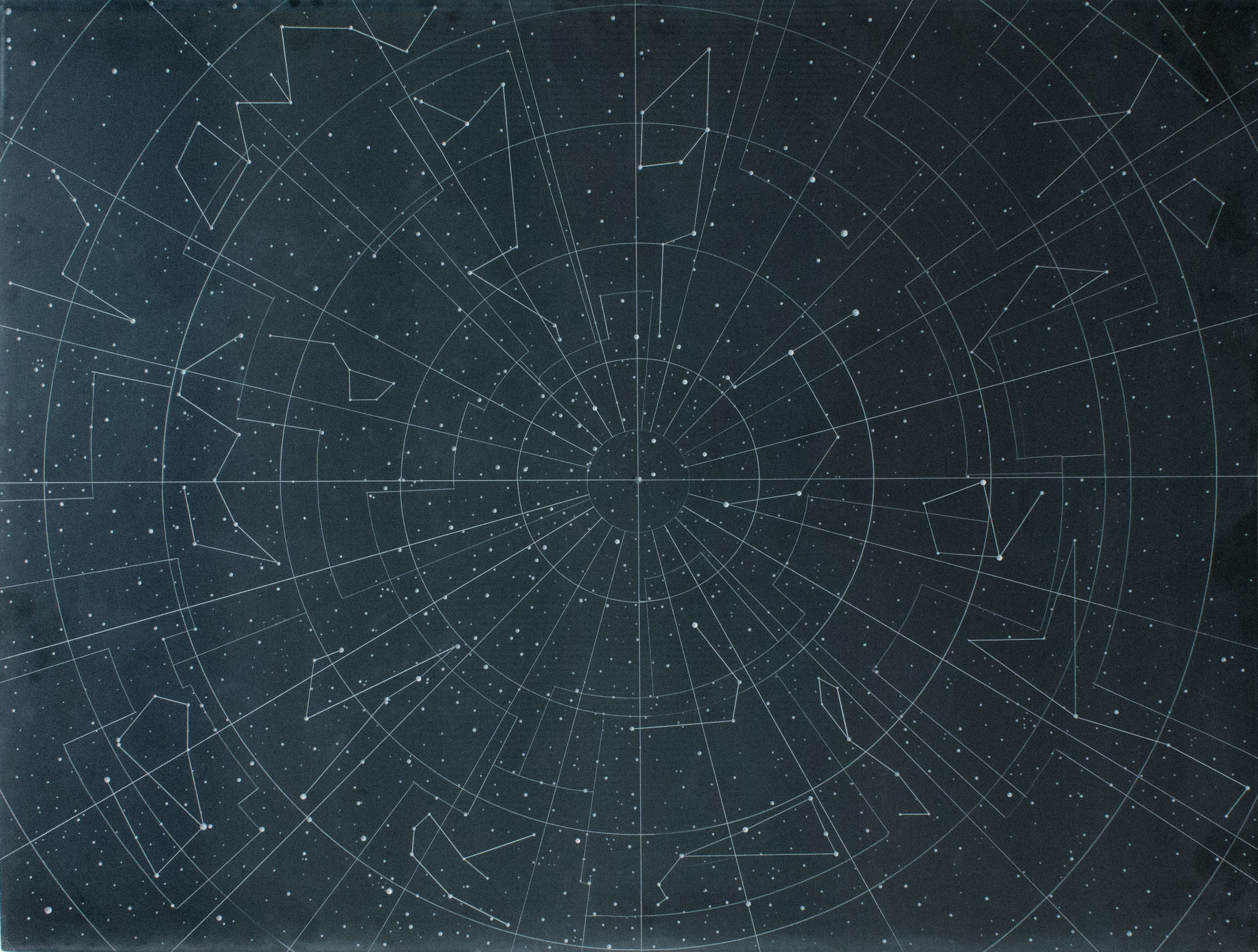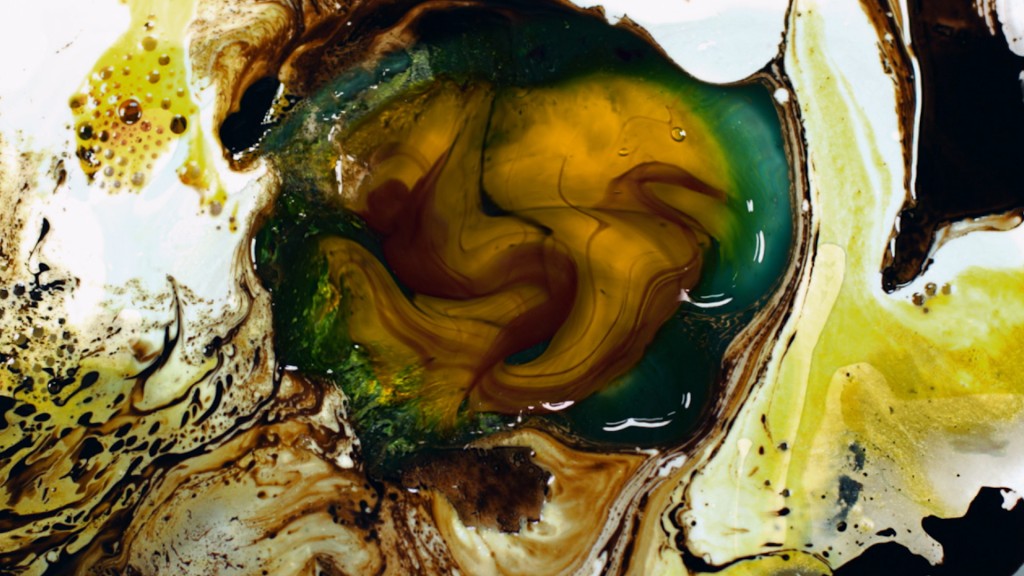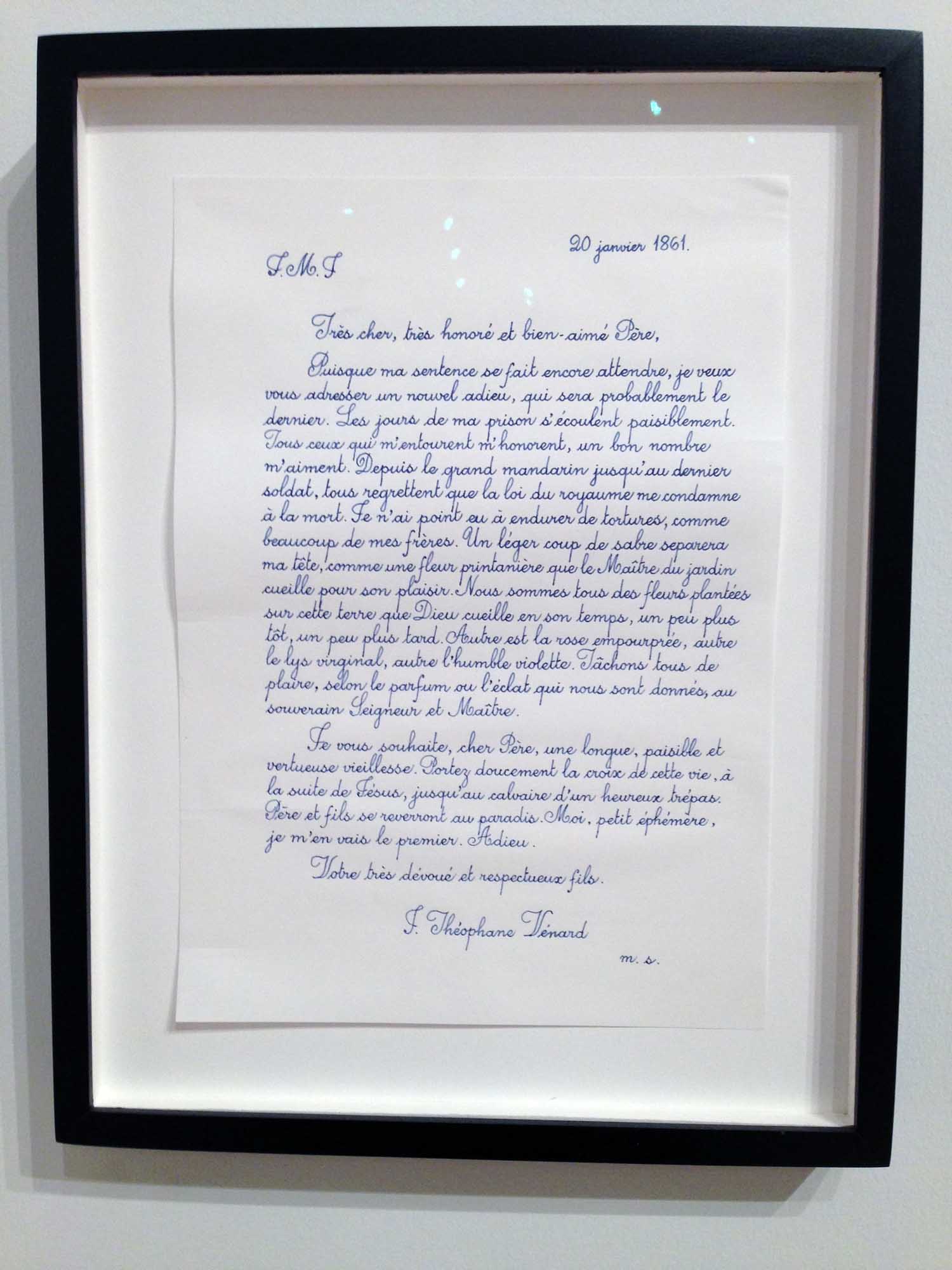Finalmente sono riuscito a vedere alla Fondazione Stelline il film di Andrea Mastrovito NYsferatu. Synphony for a Century, il remake del Nosferatu di Murnau disegnato fotogramma per fotogramma dall’artista bergamasco e la sua bottega (un corpus di 35mila disegni). La vicenda di Hutter, sua moglie e del Conte Orlok (Dracula) viene ripresa passo passo, immagine per immagine, ma a cambiare è l’ambientazione. Wisborg diventa la New York post 11 settembre e la Transilvania la Siria contemporanea devastata dalla guerra.
Come al solito il lavoro di Mastrovito abbonda, esonda, tracima. L’ambizione del progetto quasi gli sfugge di mano (non aspettatevi una sceneggiatura alla Sorkin). Ma a Mastrovito si perdona tutto in virtù della sua schiettezza, della sua immediatezza, della sua irruenza. Ma anche la sua delicatezza, la sua visionarietà, il suo umorismo.
Quante idee nella sua matita. Una su tutte, e forse quella centrale in questo film: la lacrima che scende sulla guancia della Statua della Libertà. Un’immagine che ha dentro un romanzo intero di domande: perché piange? Chi potrà consolarla?
Oggi si scrivono libri per rispondere a questi che sono gli interrogativi sulla crisi delle democrazie liberali in Occidente. Nella mia testa Mastrovito entra nella stanza dove stanno discutendo, tra gli altri, Pankaj Mishra (L’età della rabbia, Mondadori), Vittorio Emanuele Parsi (Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, Il Mulino)e Mattia Ferraresi (Il secolo greve, Marsilio). Entra nel dibattito da artista e da tifoso dell’Atalanta: lanciando fumogeni, scoppiando petardi e sfanculando la polizia.
Andate a vederlo, alle Stelline lo proiettano fino al 18 aprile