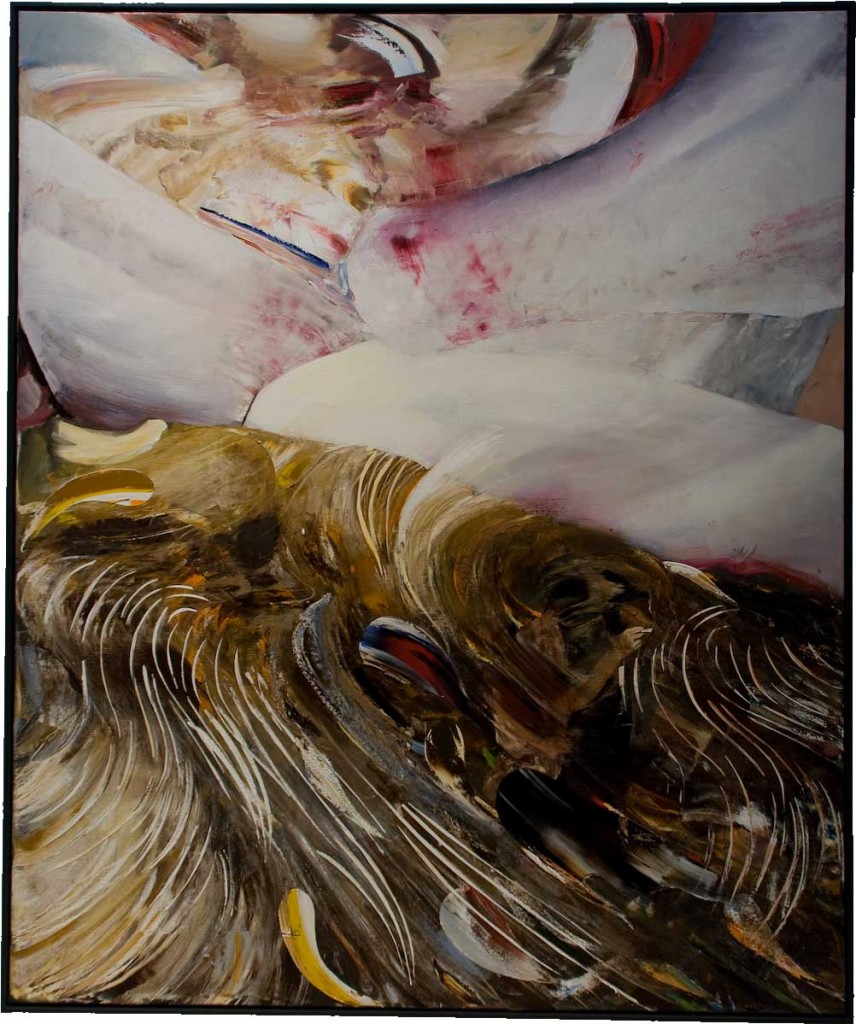Questo articolo è stato pubblicato sul numero di febbraio 2017 di Tracce
«Al momento della sua morte, che lo colse all’età di 59 anni, il 22 febbraio del 1987, Andy Warhol era per molti poco più che la parodia di un artista», ha scritto Jerry Saltz del New York Times: «Era considerato un parassita della società che viveva sulle spalle di artisti più giovani. Un individuo ormai cotto e sovraesposto, il mito di se stesso, un artista da night club che se ne andava in giro con Liza Minelli e faceva ritratti di gente famosa per soldi. Poi è morto e all’improvviso tutte le apparizioni mondane, le foto, gli show televisivi, i film, le riviste, perfino i quadri che tanta gente aveva sempre guardato con sospetto, hanno preso vita, crescendo di statura. La mia domanda è: come mai Warhol è più rispettabile da morto che da vivo?».
A trent’anni esatti dalla scomparsa del Pope of Pop, il papa del pop, ci sono diversi modi per rispondere a questa domanda. Un modo è considerare quanto accaduto alla messa di suffragio per Warhol, nella Cattedrale di Saint Patrick a New York a qualche giorno dalla morte. Per l’elogio funebre prese la parola il critico John Richardson che rivelò non solo che l’artista era un fedele volontario di una mensa per i poveri, ma che da cattolico di rito bizantino, fino agli ultimi giorni, frequentava la chiesa per la messa domenicale e per pregare durante i giorni feriali. «Chi di voi lo ha conosciuto in circostanze che erano l’antitesi dello spirituale sarà sorpreso che questo lato sia esistito», disse Richardson davanti a decine di celebrità: «Ma c’era eccome, ed è la chiave della sua mente di artista».
Per molti quel momento è stata l’occasione per riconsiderare l’opera di Warhol da un’altra prospettiva. Complice del grande fraintendimento fu lui stesso, che aveva fatto di tutto per confondere le carte: «Non prendete mai Andy alla lettera», si raccomandava Richardson. Eppure, a trent’anni di distanza, quello che appare un enigma non è stato del tutto chiarito. Come può un’arte intenzionalmente superficiale essere espressione autentica di un animo sinceramente religioso, per non dire cattolico?
I biografi hanno raccolto molti aneddoti che attestano il reale attaccamento di Warhol alla Chiesa. Qualcuno ha detto che tenesse sempre in tasca un rosario. L’amico Bob Colacello sostiene che dopo l’attentato del 1968, quando una squilibrata gli sparò lasciandolo in fin di vita, promise, se fosse sopravvissuto, di andare a messa ogni domenica. Esiste la fotografia del suo incontro con papa Wojtyla in Piazza San Pietro nel 1980. Sul suo comodino è stato trovato il libro di preghiere della sua infanzia. Richardson disse che Andy pagò il seminario a un nipote e, almeno in un caso, fu responsabile di una conversione (il critico non diede ulteriori particolari). Eppure tutti sapevano che Warhol non era un santo: la sua Silver Factory negli anni Sessanta fu per molti un luogo di autodistruzione (un esempio su tutti: il ballerino Fred Herko, che si gettò dal tetto dell’edificio). Debolezze ne aveva come tutti, e anche qualcuna in più. È evidente che il mistero non può essere risolto confidando solo sui dati biografici e limitandosi a constatare che, tra icone del consumismo e celebrità, nella sua produzione artistica compaiono anche soggetti religiosi.
 Se esiste una chiave per risolvere l’enigma, essa va trovata – questa volta sì – in profondità, cioè nella concezione che Warhol aveva di ciò che gli interessava di più: le immagini. In questo senso serve sapere che la sua famiglia proveniva da un piccolo paese nei Carpazi – all’anagrafe era registrato come Andrew Warhola – e che, giunta a Pittsburgh, frequentava la chiesa bizantina cattolica di San Giovanni Crisostomo. Quella chiesa possiede un’iconostasi e i fedeli, come fanno anche gli ortodossi, entrando, baciano le icone. Il bacio dice di un legame quasi sacramentale con l’immagine, che diventa strumento del rapporto con il divino. Il fondo oro delle icone è lo spazio eterno della dimensione sacra. E tuttavia l’icona è viva e guarda il fedele il quale, con umiltà, si lascia guardare. Anche per questo la tradizione orientale ha codificato canoni per la composizione e la simbologia a cui gli iconografi si attengono.
Se esiste una chiave per risolvere l’enigma, essa va trovata – questa volta sì – in profondità, cioè nella concezione che Warhol aveva di ciò che gli interessava di più: le immagini. In questo senso serve sapere che la sua famiglia proveniva da un piccolo paese nei Carpazi – all’anagrafe era registrato come Andrew Warhola – e che, giunta a Pittsburgh, frequentava la chiesa bizantina cattolica di San Giovanni Crisostomo. Quella chiesa possiede un’iconostasi e i fedeli, come fanno anche gli ortodossi, entrando, baciano le icone. Il bacio dice di un legame quasi sacramentale con l’immagine, che diventa strumento del rapporto con il divino. Il fondo oro delle icone è lo spazio eterno della dimensione sacra. E tuttavia l’icona è viva e guarda il fedele il quale, con umiltà, si lascia guardare. Anche per questo la tradizione orientale ha codificato canoni per la composizione e la simbologia a cui gli iconografi si attengono.
La ripetitività e la spersonalizzazione tipiche dell’arte bizantina sono le stesse che segnano l’opera di Warhol già nelle sue prime opere mature. Le lattine della zuppa Campbell sono riprodotte in modo fedele, senza volontà di interpretazione. La figura è ripetuta identica a se stessa. Gli oggetti della vita quotidiana sono offerti come un gesto di stima verso tutto ciò che ci circonda.
Quanto la pittura, in Warhol, inviti lo spettatore a far ciò che il fedele compie nei confronti dell’icona sacra, cioè entrare in rapporto reale con ciò che è rappresentato, possiamo solo supporlo. Di certo la sua era una vera e propria bulimia di realtà. In America, un diario visivo Warhol racconta che quando i giornalisti chiesero a Giovanni Paolo II che cosa gli piacesse di più di New York, rispose: «Tutto». E l’artista aggiunge: «È esattamente questa la mia filosofia».
Anche la sua passione per le celebrità, in fondo, è un modo tutto americano di celebrare il desiderio di essere voluti bene. E non appare per nulla frivolo proporre i ritratti di Marilyn Monroe, Jackie Kennedy e Liz Taylor nei momenti più drammatici delle loro vite. Anche qui: sembrerebbe l’invito a un gesto di affetto, a un bacio, a uno sguardo che entri in rapporto con ciò che di non superficiale c’è nei volti che tutti si accontentano di guardare con superficialità. Questo non significa che Warhol volesse fare arte religiosa e men che meno arte sacra.
Eppure, per uno strano destino, negli ultimi due anni si è ritrovato a lavorare in modo accanito sull’immagine di Cristo. L’occasione, abbastanza casuale, fu l’invito del gallerista Alexander Iolas a fare una mostra a Milano al Palazzo delle Stelline, a pochi metri dall’Ultima cena di Leonardo. Sarà l’ultima sua mostra, inaugurata pochi giorni prima di morire.
Jane Daggett Dillenberger, nel suo The Religious Art of Andy Warhol, ha calcolato che l’artista, comprese le versioni in cui ha usato il volto di Cristo come multiplo, lo abbia raffigurato 448 volte. Si tratta del ciclo a soggetto religioso più ampio di tutta l’arte americana. E alcune opere sono le più monumentali della produzione di Andy: The Last Supper (Red) del 1986, con i suoi dieci metri di larghezza, è perfino più grande dell’originale leonardesco.
Che Warhol si appassioni a questo lavoro è più che comprensibile: si trova a confrontarsi con una tra le immagini più mediatizzate della storia dell’arte, il cui protagonista, Gesù, a ben vedere, è la celebrità al massimo grado: Jesus Christ Superstar. Tutti lo conoscono, tutti lo amano. Non solo: quella di Leonardo è l’immagine che la famiglia Warhola aveva appesa sopra il tavolo della cucina della casa di Pittsburgh. E la madre Julia, che visse fino alla morte con il figlio, teneva nel suo libro di preghiere un santino del Cenacolo.
 L’incontro con il tema di Cristo può essere considerato, a ragione, il compimento di una poetica ormai matura, che fonda le proprie radici, come affermava Richardson, nella religiosità popolare. Il lavoro su Leonardo, ad ogni modo, non si limita a riproporre, con qualche modifica, l’immagine del Cenacolo. Warhol usa come base per i dipinti un disegno trovato in un’enciclopedia ottocentesca, e per le serigrafie una riproduzione comprata in un negozio coreano di oggetti religiosi non distante dalla Factory. Nascono così The Last Supper (Wise Potato Chips), in cui sovrappone alla scena evangelica, per indicarne l’aura di saggezza (Wise), il logo a forma di occhio di una marca di patatine fritte. In The Last Supper (Dove), usa il logo del noto sapone e una colomba. Il riferimento, suggerisce la Dillenberger, è a un episodio particolarmente caro alla Chiesa orientale, quello del Battesimo al Giordano, in cui lo Spirito Santo discende su Gesù in forma di colomba. Sulla sinistra il prezzo “59¢”, a indicare che, come i prodotti di uso comune a buon mercato, Cristo si offre a tutti. E a destra il logo della General Electric, l’azienda che porta energia e luce in tutte le case degli americani.
L’incontro con il tema di Cristo può essere considerato, a ragione, il compimento di una poetica ormai matura, che fonda le proprie radici, come affermava Richardson, nella religiosità popolare. Il lavoro su Leonardo, ad ogni modo, non si limita a riproporre, con qualche modifica, l’immagine del Cenacolo. Warhol usa come base per i dipinti un disegno trovato in un’enciclopedia ottocentesca, e per le serigrafie una riproduzione comprata in un negozio coreano di oggetti religiosi non distante dalla Factory. Nascono così The Last Supper (Wise Potato Chips), in cui sovrappone alla scena evangelica, per indicarne l’aura di saggezza (Wise), il logo a forma di occhio di una marca di patatine fritte. In The Last Supper (Dove), usa il logo del noto sapone e una colomba. Il riferimento, suggerisce la Dillenberger, è a un episodio particolarmente caro alla Chiesa orientale, quello del Battesimo al Giordano, in cui lo Spirito Santo discende su Gesù in forma di colomba. Sulla sinistra il prezzo “59¢”, a indicare che, come i prodotti di uso comune a buon mercato, Cristo si offre a tutti. E a destra il logo della General Electric, l’azienda che porta energia e luce in tutte le case degli americani.
Un altro ciclo di dipinti è intitolato Be Somebody with a Body (with Christ of the Last Supper), in cui la scritta che dà il titolo all’opera è stretta tra l’immagine di Gesù dell’ultima cena e un sorridente bodybuilder, vagamente somigliante a Warhol. Qui si innesca un cortocircuito tra l’esperienza dell’artista, che negli ultimi anni aveva iniziato a essere seguito da un personal trainer, e la figura di Cristo nell’atto di istituire l’Eucaristia. Così la frase del titolo «Sii qualcuno con un corpo» diventa una doppia preghiera, a se stesso e a Gesù: entrambi non possono restare anime disincarnate.
Monumentali e maestose sono le tre grandi serigrafie, sempre dedicate al quadro di Milano: quella rosa, quella camouflage e quella rossa. Ma forse l’immagine più sconvolgente è quella offerta da Christ 112 Times, in cui il Gesù di Leonardo viene ripetuto in modo ossessivo 28 volte su quattro ordini. Non è la prima volta che Warhol fa un’operazione simile. Ma qui diventa la maniera di rendere in immagine il modo in cui, certamente da bambino, Warhol era abituato a pregare. Tipica del cristianesimo orientale, infatti, è la giaculatoria: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore», che si ripete come un mantra decine e decine di volte: Gospodi pomilui.
Dell’ultimo periodo, poi sono anche due piccole opere, che riproducono le scritte: «Repent And Sin No More», (Pentiti e non peccare più), e «Heaven and Hell Are Just One Breath Away» (Paradiso e inferno sono a un respiro di distanza). E un piccolo e commovente Christ $9.98, un Gesù popolare davvero accessibile a tutti.
Se qualcuno avesse chiesto a Warhol perché dipingesse quei soggetti, si sarebbe limitato a un laconico: «Perché mi piacciono». Eppure il suo apparente distacco dalle cose e dai loro significati sembra essere contraddetto da una frase carpita da Pierre Restany, grande critico francese, che presenziò all’inaugurazione della mostra di Milano. «Fui sorpreso da quanto Andy mi disse quel giorno: “Pierre, pensi che gli italiani vedranno il rispetto che ho per Leonardo?», racconta il critico: «Consciamente o no, Warhol mi sembra aver agito come uno che ha cura di un capolavoro della cultura cristiana, preoccupato di continuare una tradizione di cui si sente parte».