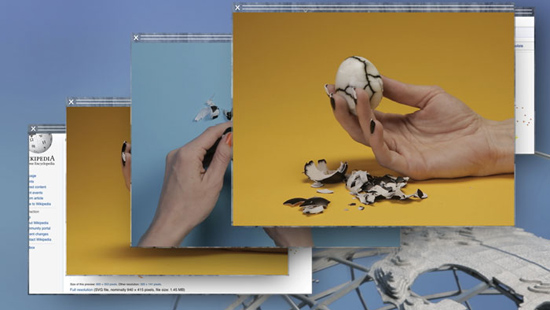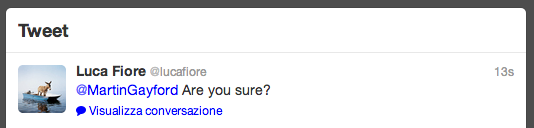Ecco il mio reportage dalla Biennale di Venezia 2013, pubblicato su Tracce di luglio/agosto:
Giovanni Testori la chiamava “biennalica balena”. Un cetaceo spiaggiato sulle rive della Laguna. Un enorme animale agonizzante, immagine di un evento che, già nel 1978, non aveva più niente da dire. Sono passati 35 anni e l’ombra di quelle parole si allunga ancora sul Canal Grande, su su, lungo la Riva degli Schiavoni fino ad arrivare ai Giardini di Castello, che con l’Arsenale sono sede della 55a Biennale di Venezia. Eppure una visita a quella che rimane la più importante manifestazione di arte contemporanea del mondo si può fare solo lasciando da parte – almeno per qualche ora – le giuste perplessità testoriane e non solo testoriane. Varrebbe la pena venirci anche solo per la vera novità del 2013: la presenza del padiglione della Santa Sede, fortissimamente voluto dal cardinale Gianfranco Ravasi e che tanto sta facendo discutere. Il Giornale dell’Arte ha titolato il numero di giugno «Il Papa alla Biennale». Papa Francesco a Venezia non ci verrà di persona, ma chi l’ha detto che proprio la Biennale non sia una di quelle «periferie esistenziali» con le quali ci invita a comprometterci?
Da Jung a Pasolini. Quest’anno la mostra principale è stata affidata a Massimiliano Gioni, giovane curatore di Busto Arsizio, ma newyorkese d’adozione. Il titolo, Palazzo Enciclopedico, è ispirato da un eccentrico emigrato abruzzese in Pennsylvania, Marino Auriti, che negli anni Cinquanta immaginò di costruire un immenso grattacielo dentro il quale raccogliere tutto il sapere umano. Gioni è un grande regista dello sguardo, capace di creare un percorso in grado di spiazzare anche gli addetti ai lavori. Su 150 artisti, circa la metà sono sconosciuti. Molti non sono nemmeno artisti di professione, ma persone che si sono ritrovate a creare immagini per i motivi più vari.
La via maestra seguita dal curatore è quella della curiosità, la voglia di capire quali siano i confini del linguaggio dell’arte. L’approccio di Gioni può apparire anti-ideologico, verrebbe da dire “formalista”. Eppure ai Giardini la mostra si apre esibendo i tre “santi protettori” del Palazzo enciclopedico: Carl Gustav Jung, primo allievo di Sigmund Freud (con il Libro rosso, codice “miniato” con l’interpretazione dei propri sogni), André Breton, teorico del surrealismo (con la maschera che ne fa René Iché), e Rudolf Steiner, pedagogo, occultista e teorico della teosofia (con le lavagne da lui realizzate durante le tante conferenze). Capito da quale punto di vista stiamo per guardare il mondo, ci si allaccia le cinture e si percorre a capofitto il caleidoscopico viaggio dentro il ventre della “biennalica balena”.
Il racconto di questo percorso andrebbe fatto per immagini. Ma avendo a disposizione soltanto le parole, facciamo il nome di qualche artista. Quello di Viviane Sassen, ad esempio, fotografa olandese che ritrae persone da Ghana, Tanzania, Zambia e altri Paesi africani: per pudore spesso lascia in ombra il volto dei soggetti. O di Maria Lassnig, la novantaquattrenne pittrice austriaca ancora in grado di far vibrare il volto e il corpo umano sulla tela di un quadro. Shinro Ohtake, con il labirinto onirico dei suoi Scrapbooks. Roberto Cuoghi, che realizza una monumentale scultura astratta, Belinda, che sembra un pesantissimo macigno in bilico. In realtà è una struttura in polistirolo coperto di polvere dolomitica e cenere ottenuta dal forno di una pizzeria. La francese Camille Henrot che, in un filmato di qualche minuto, prova a ricostruire la vita della terra dal suo inizio. Richard Serra rende omaggio a Pasolini con due parallelepipedi di bronzo scuro, attorno ai quali fanno da cornice i mari tempestosi dipinti da Thierry De Cordier.
I raggi del sole. Ma a doversi soffermare su un’opera, val la pena parlare di Blindly, il video del polacco Artur Zmijewski. Il filmato mostra alcuni adulti ciechi a cui l’artista ha chiesto di dipingere un paesaggio e il proprio ritratto. Sullo schermo appaiono uomini alle prese con una sfida vertiginosa. La loro umanità emerge con forza. Il mistero della visione appare in tutta la sua insondabile profondità. A un certo punto uno dei “pittori ciechi” dice: «Devo dipingere il sole? Qui scelgo il pennello, le dita non vanno bene. Dicono che i raggi del sole sono fili sottili, le tracce delle dita sarebbero troppo spesse». Verso la fine del video si vede una mano impiastrata di colori. Una delle immagini indimenticabili di questa Biennale.
Oltre la mostra di Gioni, alla Biennale sono presenti 88 padiglioni nazionali. Il più bello? Forse quello dell’Irlanda. Il fotografo Richard Mosse ha portato un filmato realizzato nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Qui, dal 1988 sono morte quattro milioni di persone in una guerra dimenticata. Nel suo tentativo di reinventare la fotografia di guerra, Mosse aveva iniziato nel 2009 a scattare immagini con la pellicola a infrarossi. Sul rullino si imprime lo spettro di luce non visibile all’occhio umano. Le foto mostrano, cioè, quel che c’è ma non si vede: una metafora non solo della guerra dimenticata, ma anche un tentativo di mostrare ciò che ci sfugge di quel che guardiamo. Le immagini, poi diventate anche un filmato, sono di una bellezza tragica: il verde della foresta rigogliosa diventa di un magenta-rosa profondissimo. Una scossa. Anche per i cuori più impenetrabili.
È solo dopo aver attraversato gli oltre 10mila metri quadrati dell’esposizione principale e messo il naso nei padiglioni nazionali più importanti, che si può prendere la misura della sfida lanciata dal cardinale Ravasi portando la Santa Sede a Venezia. Se per le singole nazioni si tratta di presentare gli artisti più significativi del momento, oggi la Chiesa torna a riflettere sul proprio rapporto con l’arte contemporanea. Una ferita, un divorzio, il teatro di profonde incomprensioni. La via scelta non è quella di proporre una mostra di arte sacra, ma di suggerire ad alcuni artisti di primo livello (cosa nient’affatto scontata) un tema di lavoro, quello dei primi undici capitoli della Genesi. Si trattava di riallacciare un rapporto non tanto con l’arte contemporanea in generale, ma con alcuni uomini, chiamati a coinvolgersi in prima persona con opere realizzate per l’occasione. La scelta è caduta sul collettivo milanese Studio Azzurro, il fotografo ceco Joseph Koudelka e l’artista australiano Lawrence Carroll. Come ouverture sono state scelte tre opere che il pittore Tano Festa realizzò in omaggio al Michelangelo della volta della Cappella Sistina. Quella di Studio Azzurro è l’opera che più si fissa nella memoria. Su tre schermi vengono proiettate immagini di persone che camminano in uno spazio indefinito. Se lo spettatore appoggia la mano su una figura, questa si ferma e si rivolge verso di lui “pronunciando” alcune parole. Nel primo e nel secondo schermo, vengono mimati con l’alfabeto dei muti nomi di piante o animali. Nel terzo – ed è il momento più toccante di tutto il padiglione – i protagonisti sono alcuni detenuti del carcere di Bollate. Quando vengono toccati si fermano e appoggiano entrambe le mani sullo schermo. Iniziano a dire il proprio nome, quello dei genitori e dei genitori dei genitori. Mentre parlano può capitare che le nostre mani tocchino le loro. È quasi come essere nel parlatorio di un carcere. Dio comandò con la parola e le cose furono create, sembra suggerire Studio Azzurro, ma in quel momento non c’era ancora nessuno in grado di ascoltare quelle parole. L’uomo, invece, è creato proprio per pronunciare il proprio nome, per dire «io».
«Voi siete maestri». Missione compiuta? Più che altro è un’avventura iniziata di nuovo. Si potevano scegliere altri artisti? Certamente. Ma il Cardinale ha intrapreso la sfida con il suo stile, ed è giusto che sia stato così. Quel che colpisce, rispetto al contesto della Biennale, è vedere come altrove l’immagine artistica cerca di svincolarsi dalla parola. Cerca cioè di dire ciò che le parole non arrivano a dire. Nel padiglione della Santa Sede, invece, all’immagine è chiesto, in qualche modo, di tornare alla parola. E non una parola a caso. Questo scarto è forse il grande problema. E non è detto che sia risolvibile in modalità convincenti. Ma se è così, è proprio necessario che questa riconciliazione avvenga? Non basterebbe rifarsi alle forme del passato, così riuscite e ammirate? Verrebbe da dire: no, non basta. Se è vero che Cristo o è contemporaneo a noi o non è, gli artisti di oggi devono giocarsi per quello che sono, da poveri uomini moderni, con la loro sensibilità e gli strumenti che hanno a disposizione. Guardare indietro sarebbe una scorciatoia. Usciti dal padiglione della Santa Sede, lasciandoci alle spalle la candida opera di Carroll, tornano in mente le parole di Paolo VI agli artisti: «Noi abbiamo bisogno di voi, voi siete maestri». Con questi pensieri, e molte immagini nella testa, si prende la direzione di San Zaccaria per salire sul vaporetto del ritorno. Un po’ come Giona sputato fuori dal ventre della balena. Che torna a riveder le stelle.